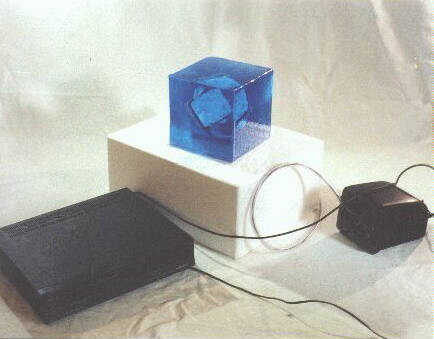
DAVID REIMONDO
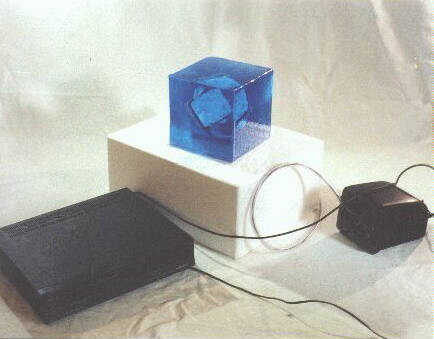
Quale
sia stata la sostanza dell’immagine è agevole da stabilire: un calco. Secondo la tradizione religiosa
dell’occidente l’uomo stesso è immagine, ipotetico calco del suo creatore. Che
non lo si realizzi più con il fango, come nel racconto della Genesi, o con la
cera – come si faceva in antiquo con i volti dei morti – o ancora con la
traccia pittorica, come nel mito narrato da Plinio del primo artista spinto a
fissare il suo profilo dall’ombra proiettata sul muro, ma con tecniche relativamente nuove (la
fotografia, il videotape, i softwares digitali) non è decisivo. Calco, sindone,
fotografia: non soltanto volumi o colori disposti nello spazio, ma spazio
complesso di intermediazione fra le cose, il corpo (la cosa che è il corpo),
l’idea. L’eidos, appunto, forma opposta a materia, qualità, carattere
specifico, essenza, tipo, metodo, maniera, bellezza. Inquietante per la
possibilità di animarsi, acquisendo “moto e respiro”, come scrive Settis. Osteggiata come schermo idolatrico e
venerata al tempo stesso da chi vi coglieva invece “una presenza
dell’indicibile che scaturisce dalla materia” (Sendler).
Apparentemente
sopita - e stranamente, in un’epoca in cui l’“animazione” dell’immagine ha
raggiunto una effettiva producibilità tecnica - la tensione fra iconoclasti e
cultori dell’immagine lascia spazio oggi ad una più spinta tematizzazione di
questa come luogo in cui presenza e assenza si sovrappongono per dare luogo ad
una realtà supplementare (Lanier). Tenendoci al campo, ristretto ma
particolarmente significativo, della figura umana, notiamo una divaricazione
accentuata fra i lavori artistici che documentano le ricerche condotte nella
linea del post-umano e quelli impostati sull’appearance. Nei primi è la
manipolazione reale, cruenta, del corpo ad integrare l’opera. Negli altri la
messa in scena di identità fittizie, di cerimoniali recitati a vuoto, di
travestimenti. La scrittura foto e videografica applicata ai due modelli
produce, paradossalmente, esiti antitetici: depotenzia ciò che è reale,
realizza il fittizio. Ma, in qualche modo, queste declinazioni sembrano
riprodurre uno schema proprio di una situazione non più attuale, definito già
negli anni ’60 tra le polarità opposte delle “antropometrie” di Yves Klein e
delle Marylin di Andy Warhol. Lo
slittamento che si sta verificando, grazie anche alle nuove modalità di
elaborazione ed ai nuovi supporti, sembra indirizzarsi verso un’immagine che
non è più un oggetto - sia pure sui generis - da produrre ma, in qualche
modo, uno stato di realtà indipendente al quale si può accedere e di cui ci si
applica a cogliere il flusso.
In
questa prospettiva si colloca il lavoro di David Reimondo, attivato da immagini
di corpi trascelte da registrazioni video, sottoposte ad una scansione da parte
di macchinari che ne analizzano la frequenza luminosa e quindi digitalizzate e
stampate, per essere poi ricoperte da uno spesso strato di resina che
attraverso la sua consistenza gelatinosa e la sedimentazione ondulata
conferisce all’insieme una parvenza mobile e traslucida, che mima il movimento
impercettibile dei pixels su un monitor. Profili attraversati dalla luce che
emergono dallo sfondo azzurro come da una profondità siderale, che l’artista ha
chiamato “Anime” per sottolinearne il carattere immateriale, il tratto di
“automovimento” che è loro connaturato. E che sovente ritornano alla dimensione
originaria, in lavori come “Feeding” (1999) ove l’immagine viene emessa da un
monitor incapsulato, anch’esso, nella resina, o in una installazione senza
titolo dello stesso anno dove lo schermo, nascosto dietro un pannello finge a
sua volta la configurazione del quadro.
Si
modula così un confronto tra fissità mobili e mobilità stabili che affranca, in
certo modo, l’immagine dal mezzo; che scavalca la nozione di “corpo intercambiabile”,
preconizzato per il cibernauta da Eric Gullichsen, per mettere a fuoco l’essenza stessa dell’immagine rintracciata
nel ruolo intermedio fra sensibile e soprasensibile che Platone riconosceva
all’anima.
s.r. (2000)