Rainer Wittenborn: De Finibus Terrae

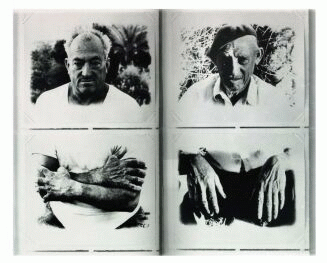
Il primo, “De
Finibus Terrae”, esposto per la prima volta nel 1991 presso la Fondazione
Mudima di Milano, condensa una ricerca condotta – come annotava nel catalogo
allora pubblicato Vittorio Fagone – “tra arte e antropologia” nella penisola
salentina. L’artista esplora il
territorio con un approccio totalizzante, che dagli aspetti naturalistici (i
diversi minerali, accostati sul pavimento a formare la parola “terra”; la
vegetazione che costituisce il soggetto de “L’olivo e l’oleastro”) si estende
a componenti storiche (le lotte per la riforma agraria, su cui l’artista
incentra “La legge e le terre”) e a fenomeni sociali come l’emigrazione,
evocata ne “I ritornati”, sequenza fotografica focalizzata sui volti e le
mani dei lavoratori rientrati in patria dai paesi della Mitteleuropa. Alla complessità
tematica corrisponde una vasta articolazione linguistica, in cui elementi oggettuali,
reperti fotografici, si affiancano ad una varietà di interventi grafici e ad
una impaginazione visivamente efficace, ottenuta legando gli uni agli altri
riquadri di carta così da formare una sorta di quinta spiegata davanti alla
parete, che congiunge le diverse componenti senza comprimerne l’autonomo
rilievo. Il secondo ciclo
(“Amazon of the North: James Bay revisited”, 1995) tocca invece il problema
dello sfruttamento della natura e degli sconvolgimenti portati
nell’ecosistema. Il caso è quello, sintomatico, di James Bay, su cui
l’artista aveva già appuntato la propria attenzione nel 1979, dando vita al
“James Bay Project”. Qui la messa in atto, da parte della Hydro Quebec, di un
programma idraulico che contempla la creazione di un bacino di ampie
proporzioni a Great Whale, pone in pericolo l’esistenza delle foreste, la
sopravvivenza di specie animali (la “phoca vitulina mellonae”) e delle stesse
popolazioni autoctone (Cree e Inuit). “Northern Creatures
– Species or Subspecies?” presenta appunto profili di foche, sospese a
mezz’aria, come tratte fuor d’acqua, fissate a sottili supporti disposti in
diagonale che alludono ad arpioni. In alto un pannello fotografico definisce
i contorni del luogo, mentre unl bastone da geometra introduce, attraverso la
neutralità di uno strumento tecnico, l’aggressività dell’intervento umano. In
questa installazione, come in “The great Flood – On or Off”, che conclude il
percorso dell’esposizione, si nota una scansione spaziale di vasto respiro,
modellata sulla dimensione sconfinata degli scenari canadesi. Nell’insieme, però,
la mostra sembra scontare il limite di una concezione dell’arte
puntigliosamente legata all’impegno politico ed ecologico. Può essere che la
lezione che Wittenborn, secondo quanto attesta Nina Felshin, ha tratto
dall’arte concettuale, vale a dire che ”il significato dell’opera d’arte non
sta nell’oggetto in sé, ma piuttosto nel contesto fisico, politico e
culturale di cui è parte”, sia corretta. Ma da questo non
deriva che “i problemi del mondo reale, compresi quelli che riguardano
l’ambiente” possano diventare “non solo il soggetto ma anche il mezzo
espressivo dell’arte”. Così, al di là
dell’indubbia padronanza formale, ci si domanda se l’arte non si ritragga di
fronte ad un eccesso di consapevolezza e se ad emergere non sia, in
definitiva, un intento didattico. E, mentre appare
innegabile la tempestività dell’impresa di Wittenborn di fronte all’odierno
affiorare di un nuovo interesse per le culture marginali, radicate in
ambienti compromessi da uno sfruttamento indiscriminato, è proprio l’evento clou
di questa tendenza, la quinta biennale di Lione allestita da Jean-Hubert
Martin, “Partage d’Exotismes”, con la sua vivacità ingenua e frenetica, il
suo melting pot di giovani artisti africani ed asiatici, a confermare
che le più validide interpretazioni di realtà a lungo misconosciute vengono
da quanti le vivono senza mediazioni. s.r.
(settembre 2000) |
HOME PAGE
ARCHIVIO ARTISTI
MOSTRE A GENOVA